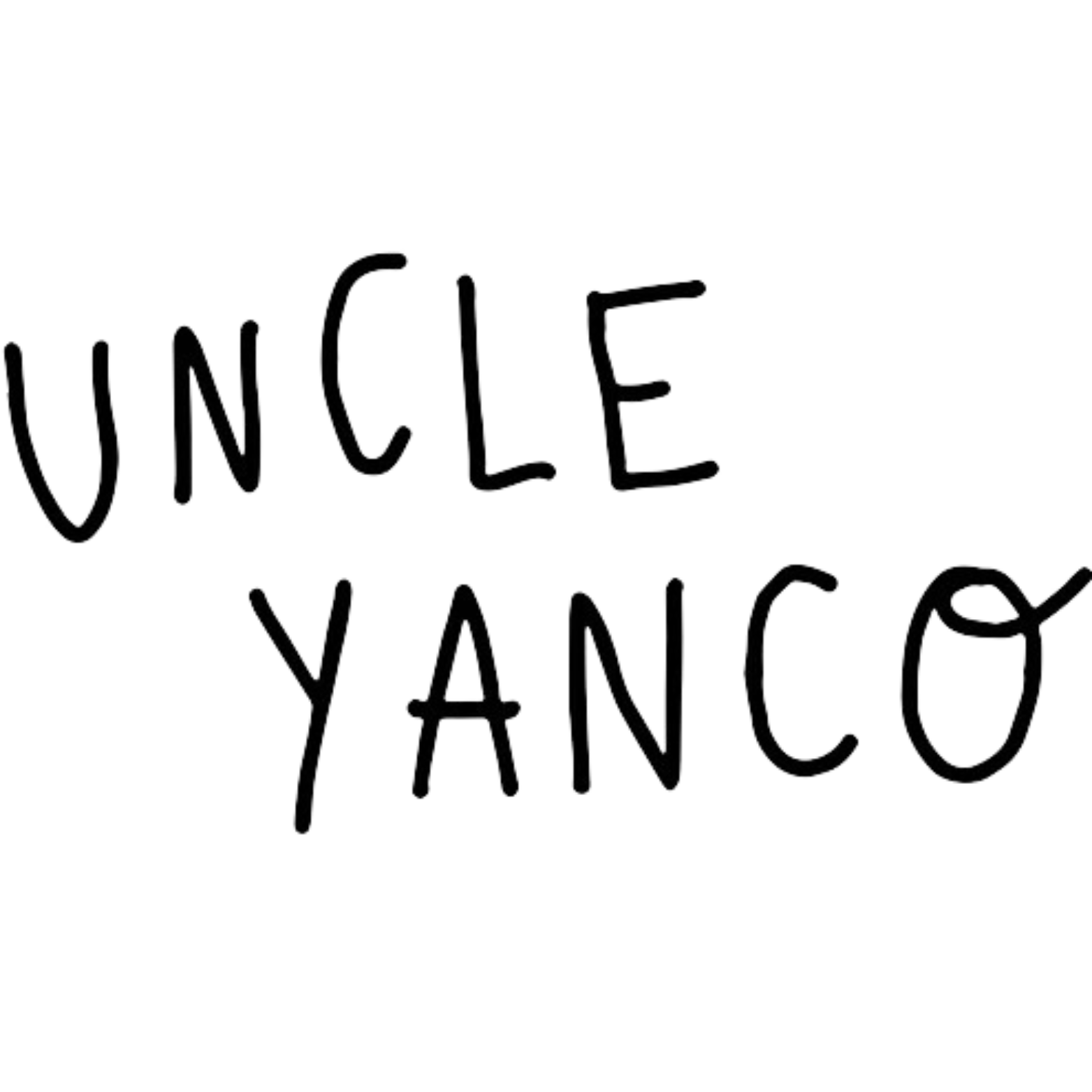di giulia
Dopo Asteroid City sono state molte le critiche rivolte a Wes Anderson: troppa tecnica, poca sostanza; troppo stile, poco contenuto; puro design, non cinema. A questo giro Anderson, con una serie di quattro corti — il più lungo presentato al Festival di Venezia e ora tutti disponibili su Netflix — si diverte ad esasperare proprio il soggetto, la storia, la narrazione delle sue opere. Si ritorna ancora una volta sul concetto da lui tanto amato dello storytelling, con la differenza che in Asteroid City la conversazione era più strettamente legata al cinema e al teatro, adesso si parla del narrare nella sua pura forma. Non esiste altro se non l’atto di raccontare, protagonista assoluto di questi quattro film.

Per la creazione dei corti Wes Anderson lavora riadattattando allo schermo alcune storie di Roald Dahl, scrittore britannico conosciuto soprattutto grazie i suoi romanzi per l’infanzia — per fare due titoli, dobbiamo a Dahl la realizzazione di lavori come La fabbrica del cioccolato (1964), Il GGG (1982) e Matilda (1988). Partendo da The Wonderful Story of Henry Sugar, il più lungo dei quattro con una durata di circa 40 minuti, notiamo come il film recita il testo di Dahl quasi completamente alla lettera, fino all’ultimo “io dissi“. Non è la prima volta che il regista fa utilizzo delle opere dello scrittore, citando il celebre film in stop-motion Fantastic Mr. Fox (2009), tuttavia a questo giro lo fa in modo più diretto e secco, anche se sempre incorniciato dal suo inconfondibile modus operandi.
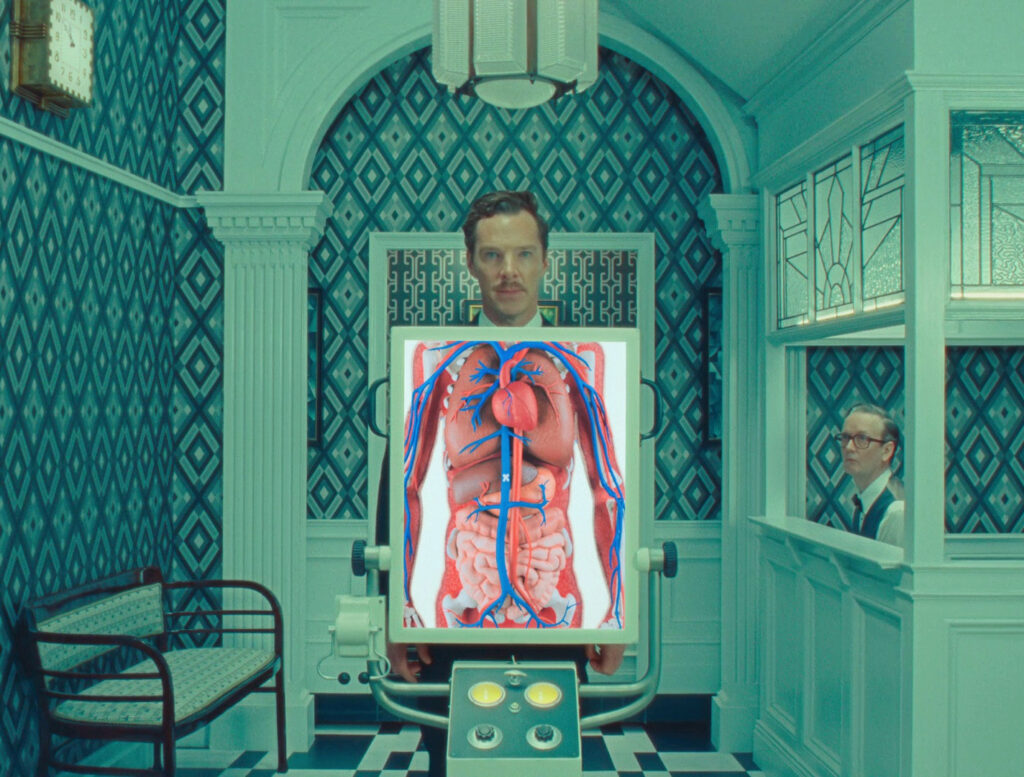
La novella parte con un Ralph Finneas nei panni di Dahl stesso, che prende la voce di narratore. Ben presto la parola passerà a una serie di nuovi personaggi, inseriti dal regista con attenzione, tenendo conto di descrivere nel dettagio, con la sua solita ironia, tutte le loro caratterisctiche del caso. Dev Patel come il Dottore Chatterjee, Ben Kingsley come “l’uomo che sapeva leggere senza gli occhi”, Benedict Cumberbatch come il ricco Henry Sugar. Grandi attori che non avevano mai lavorato in precedenza con Anderson e che adesso spero entrino a fare ufficialmente parte della sua ricorrente crew. Tutti i protagonisti prendono la parola a turno, raccontandoci a voce le loro azioni in contemporanea a quando le vediamo sullo schermo, “uscendo” momentaneamente dalla scena e girandosi verso lo spettatore rompendo la quarta parete. Questo crea una sorta di intesa divertente, che ci fa percepire il corto come una delle tante favole della buonanotte che i nostri genitori ci raccontavano da bambini.

“Uomini come Henry Sugar possono essere trovati alla deriva come alghe in tutto il mondo. Non sono uomini particolarmente cattivi, ma non sono nemmeno uomini buoni. Fanno semplicemente parte della decorazione.” Siamo così avertiti che la storia di Henry Sugar racconta di un uomo come tanti, il quale, anche se già benestante di estrazione, diventa ossessionato dal suo nuovo progetto di guadagno. Durante una festa in una casa di campagna, Henry rimane affascinato da un volume che trova per caso in biblioteca: una casistica medica dell’artista teatrale indiano Imdad Khan, scritta dal medico di Khan, Dottor Chatterjee. La stranezza del caso ricade sul fatto che quest’uomo, grazie ad un rigidissimo allenamento che segue le pratiche della meditazione, ha imparato a vedere anche senza tenere gli occhi aperti. Sugar si convince così di studiare la tecnica per poter barare a carte e vincere tutti i soldi che vuole, senza limiti. Un uomo ricco che mette tutto se stesso nel diventare ancora più ricco, non una novità in questo mondo moderno.

Tuttavia la storia di Henry Sugar lascia sul finale spazio a una redenzione del ricco scapolo, che possiamo credere o non credere essere genuina. Come recita il personaggio di Ben Kingsley riferendosi a questo miracolo: “Il pubblico lo adora. Applaudono a lungo e forte. Ma nessuno crede che sia autentico. Tutti pensano che sia solo un altro trucco intelligente. E il fatto che io sia un prestigiatore li fa pensare più che mai che io stia fingendo. I prestigiatori sono uomini che ti ingannano. Ti ingannano con l’astuzia. E quindi nessuno mi crede. Persino i medici che mi bendano nel modo più esperto si rifiutano di credere che qualcuno possa vedere senza gli occhi. Dimenticano che potrebbero esserci altri modi per inviare l’immagine al cervello”.

A differenza di The Wonderful Story of Henry Sugar, gli altri tre corti virano su storie più cupe. In particolare The Swan si allontana particolarmente dallo stile giocoso dei lavori di Anderson, approfondendo un territorio più buio. Rupert Friend è il nostro narratore, che a questo giro non passerà la parola a nessun altro personaggio. Scopriremo a corto iniziato il motivo per cui il personaggio di Friend è l’unico che ha il diritto di raccontare questa storia, con tanto di voci alterate per farci riconoscere quando sono terzi a parlare. Il cigno narra la storia di un giovane di nome Peter Watson, attaccato incessantemente da due bulli che lo sottopongono a prove crudeli e potenzialmente mortali. Capiamo che Peter è sopravvissuto quando ci rendiamo conto che Friend interpreta la sua versione adulta, raccontandoci quindi la storia dal suo personale punto di vista. Questo però non è abbastanza per darci sollievo, perchè The Swan con la sua freddezza ci lascia addosso un setimento amaro. “Alcune persone, quando hanno subito troppo e sono state spinte oltre il limite di sopportazione, semplicemente crollano, crollano e si arrendono. Ce ne sono altre, tuttavia, anche se non sono molte, che per qualche motivo saranno sempre invincibili. Le incontri in tempo di guerra e anche in tempo di pace. Hanno uno spirito indomabile e niente, né il dolore, né la tortura, né la minaccia di morte, le farà arrendere. Il piccolo Peter Watson era una di queste”.

Un simile sentimento di disagio resta in noi anche dopo la visione di The Rat Catcher e Poison, che nascondono entrambi all’interno della loro trama apparentemente comica fondi di verità molto più dure. Poison mostra un incredibile Dev Patel che ci porta attraverso la storia narrando il tutto a un ritmo sempre più incalzante e davvero notevole, dandoti addirittura l’impressione di aver toccato per sbaglio sul pulsante di Netflix che ti permette di accellerare la velocità della riproduzione. Benedict Cumberbatch interpreta un inglese di nome Harry Pope, che una sera viene scoperto nel suo bungalow di epoca coloniale in India, sdraiato assolutamente immobile sul suo letto, visibilmente in ansia poichè un velenossissimo serpete si è addentrato sotto le sue lenzuola. L’unica speranza per sopravvivere è chiamare il Dottor Ganderbai (Ben Kingsley), che si dà il caso essere indiano. In neanche venti minuti Anderson rende il corto una sorta di thriller, mettendoci di fronte a disturbi post traumatici da stress che sfociano in rabbia e manifestazioni di razzismo. L’ironia rimane presente se pensiamo a come Roald Dahl sia stato più volte criticato per il suo linguaggio offensivo, carico di stereotipi razzisti e sessisti, tanto da portare a riedizioni dei suoi libri che oggi non presentano più questi aspetti.

Arrivando alla fine, The Rat Catcher è forse la più surreale di queste opere. Apparentemente il film parla di un uomo bizzarro (Ralph Finneas) incaricato dal dipartimento sanitario di risolvere un problema d’infestazione di topi. Questo però non è assolutamente il cuore della storia. Il modo in cui il cacciatore di topi parla ci risulta familiare, con una impostazione troppo politica e autoritaria per essere considerata un caso. Conoscendo Dahl, e ormai avendo capito l’andamento dei corti, è facile scovare una nuova sottotrama colonialista. Mettendo in scena elementi da film horror, senza mai però mostrarceli visualmente ma solo attraverso la narrazione, il regista ci racconta l’ennesima storia di un uomo ignorante che trova soddisfazione solo quando sovrasta la generica vittima da lui presa di mira. Wes Anderson ci comunica tutto questo non solo attraverso il film, ma attraverso il processo stesso di realizzazione. Mostrando ancora una volta la sua eccezionalità, sfida i confini del mezzo cinematografico, creando così nuove possibilità per ridefinire l’essenza del cinema stesso. Ti prego Wes, non smettere mai.