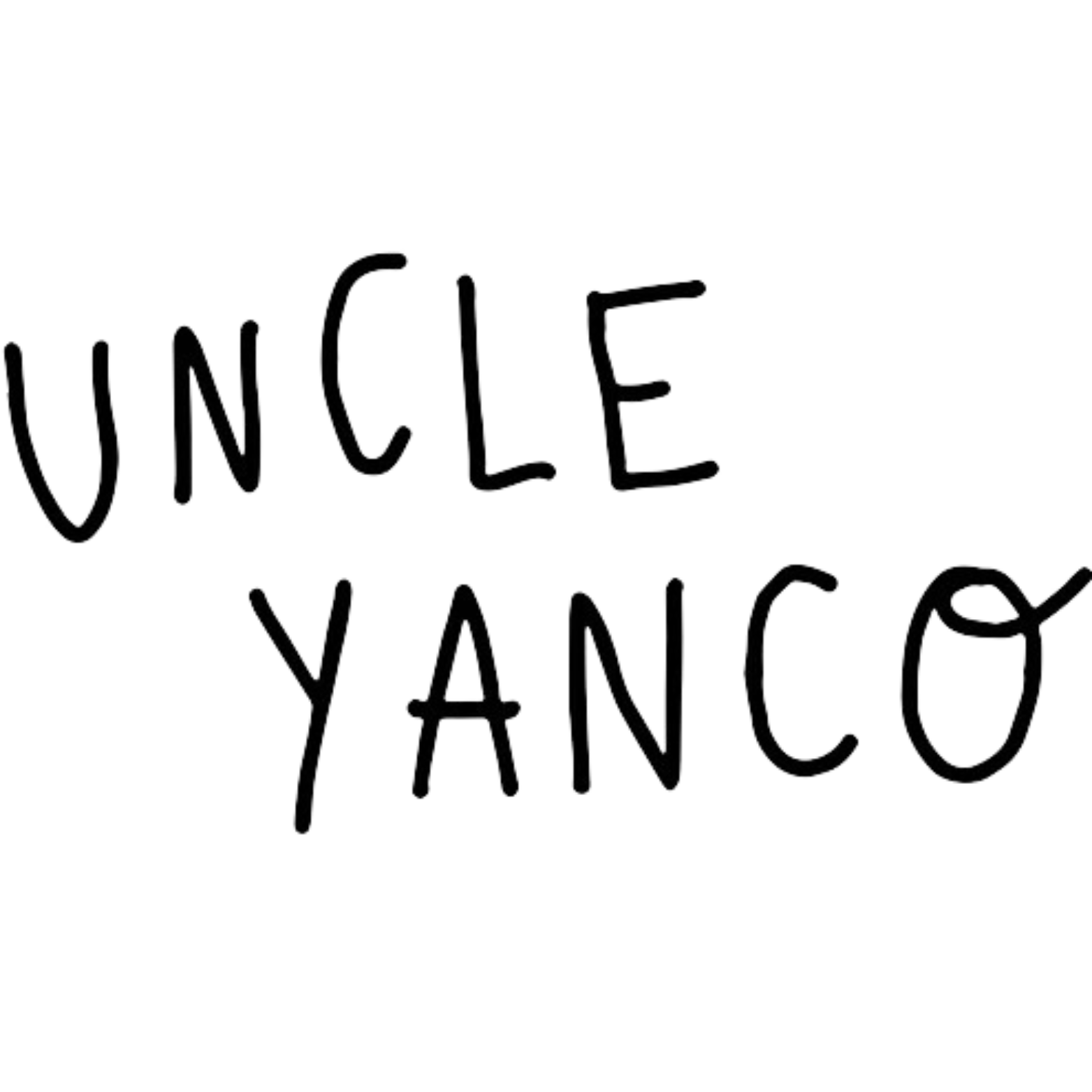di giulia
Nonostante siano passati svariati giorni dalla mia visione di Babylon di Damien Chazelle continuo a non avere una risposta alla domanda: insomma, ti è piaciuto il film? Mi trovo a concordare sia con recensioni da cinque stelle che elogiano ogni aspetto della pellicola, sia con chi le ha rivolto le critiche più amare. Mi sono divertita al cinema, nonostante i 189 minuti il film tiene alta l’attenzione per quasi tutta la sua durata — perdendosi tuttavia un po’ sul finire. Tecnicamente parlando il film raggiunge livelli molto alti. La ripresa iniziale della festa, che mira a introdurci all’interno delle dinamiche caotiche di una nascente Hollywood passando a inquadrare tutti i personaggi della storia, è a mio avviso una delle scene migliori dell’anno.

Il problema più grande di Babylon, tuttavia, non è necessariamente il fatto che Chazelle stia usando come modello per la sua narrazione film che in realtà funzionano molto meglio del suo, ma che la sua intera tesi sia in contrasto con la natura di Singin’ in the Rain, come se fosse il primo a sfatare profondamente qualche falsità relativa a Hollywood. Avere un punto di vista concreto è una cosa positiva, ma lui ha un’agenda così precisa che le strategie usate per esporci questo punto di vista diventano non sincere e — oltrepassando l’apice della festa — molto deboli, in questo film che si trasforma quasi in un saggio accademico non troppo originale. E’ presente, per quasi tutto il film, questa brutalità che lui tenta di rendere emotivamente risonante senza troppi risultati. In mezzo a tutto questo ci sono idee e momenti che però funzionano, la rappresentazione della bellezza di un processo creativo sfrenato: ad esempio Manny che porta sull’ambulanza l’ultima macchina da presa in tempo per cogliere la luce perfetta sulla scena finale del film o i numerosi tentativi di ripresa dopo l’introduzione del suono. Purtroppo però, questo sentimento genuino spinto dalla passione di fare cinema, non regge l’intero percorso e sparisce.

Tutto gira intorno a questo caos, questa irrefrenabile follia esagerata, in linea con un’industria che ha l’abitudine di sovradimensionarsi in tempi di crisi. Per raccontare la sua storia, Damien Chazelle ha riportato indietro le lancette dell’orologio agli anni immediatamente precedenti l’adattamento del suono sincrono come standard industriale. In linea di massima, inquadra questo periodo come un’epoca di sfrenata libertà personale, un’epoca in cui i cinefili facevano festa, tracannando fiumi di alcol e facendo uso di qualsiasi droga conosciuta al tempo, gioiosamente al ritmo di jazz. Babylon è incentrato su diversi prototipi di questa industria: una star affermata del cinema muto, un’attrice nascente estremamente confidente nelle fatto di diventare una stella e un esterno ammiratore della magia di Hollywood, disposto a fare qualsiasi cosa pur di entrare a far parte attivamente di quel mondo. Ho apprezzato le parti in cui è visibile una critica del modo in cui l’avidità capitalistica bianca di Hollywood ha imposto, e impone tuttora, l’assimilazione ai sogni degli emarginati, costringendoli poi a rivoltarsi l’uno contro l’altro, mettendo in luce chi non può vivere senza il business e chi invece deve andarsene se vuole mantenere la propria integrità creativa. Ma il desiderio di voler dire troppo ha fatto si che gli aspetti realisticamente interessanti del film siano stati schiacciati dai momenti di caotico niente, esempio di ciò a mio avviso, l’intera storyline di Lady May (Li Jun Li).

Il film si muove al ritmo di colonna sonora brillante, le musiche di Justin hurwitz sono impeccabili e sono forse queste, più che la trama stessa, ad aiutare la visione in modo scorrevole rendendo le scene mai noiose. Tuttavia Babylon non riesce a capire dove andare una volta finita la festa, e l’energia creativa che si accumula all’apice dell’edonismo finisce per collassare su se stessa. Non c’è molto da vedere oltre allo spettacolo delle sue parti che girano freneticamente, il che potrebbe essere tollerabile se non ci fosse un notevole squilibrio fra le prime due ore e la seconda parte del film. Questa frenesia è inizialmente utile alla storia e al concetto di eccesso delirante dell’epoca che Chazelle vuole passarci, ma la mancanza di una conclusione della sua tesi diventa a tratti pesante.

Nellie LeRoy (Margot Robbie) vuole diventare una star, o meglio, crede di esserlo già, mentre Manny Torres (Diego Calva) desidera lavorare nel mondo del cinema in qualsiasi veste: dipendente per feste sfarzose, trasportatore di elefanti da intrattenimento, faccendiere per l’idolo del cinema muto Jack Conrad (Brad Pitt), fino ad assumere posizioni incerte in uno studio cinematografico (quando viene chiesto se è “un produttore”, risponde che è un “executive director”). A Manny basterà una conversazione piena di sogni e di speranze per cadere ai piedi di Nelly. Fin da subito non è difficile capire che l’energia di questa donna porterà confusione, se non peggio, nella vita dell’ingenuo ragazzo, ma come biasimarlo, il sorriso di Margot Robbie è più forte di qualsiasi senno di logica. Nel corso degli anni a seguire i loro incontri sono brevi, ma sempre abbastanza intensi per ricordare a Manny quanto si senta vicino a questa ragazza, che come lui, condivideva lo stesso sogno di far parte di qualcosa più grande di loro. Mentre le fortune dei due giovani cambiano, cambia anche il mondo a cui hanno venduto l’anima: i film passano dal cinema muto a quello sonoro, mentre l’illegalità da selvaggio immaginario Western dell’industria emergente non regolamentata lascia il posto a qualcosa di più controllato, di più etico. Il personaggio di Jack Conrad ci rimanda a uno stereotipo della storia del cinema che conosciamo bene. Per quanto lo riguarda, i film sono troppo giovani per essere già invecchiati. Certo, questo è quello che Chazelle probabilmente cercava, l’ennesima storia di “ascesa e declino” di una grande stella del cinema, che riconosca la necessità di un’evoluzione, ma che rimane comunque troppo attaccata ai riflettori per rendersi conto di essere già stata relegata al passato. Poco confortante è il modo in cui la giornalista di gossip Elinor St. John (Jean Smart) cerca di placare i crescenti timori di irrilevanza di Jack: passerai l’eternità con angeli e fantasmi, una pillola difficile da ingoiare per un idolo del cinema che ama il cinema più di tutte le sue mogli a rotazione.

Arrivando alle conclusioni, Babylon è un film che si nutre del suo essere eccessivo, degli stereotipi, di una colonna sonora impeccabile, di un lavoro dal punto di vista tecnico magico e infine di sogni, desideri, disillusioni. Credo che Chazelle abbia fatto tutto perché voleva catturare l’insondabile emozione di costruire Hollywood dalle fondamenta, di creare un sistema che offrisse alla gente la possibilità di entrare a far parte delle più alte vette del cinema. La principale delusione però è che ci sono molte cose che sarebbero potute essere messe a fuoco maggiormente peril raggiungimento di un risultato migliore, ma Chazelle è più innamorato delle dimensioni della sua tela che di qualsiasi altra cosa. Molti dei momenti migliori sembrano più un omaggio a Paul Thomas Anderson che alla vecchia Hollywood — compreso il personaggio di Tobey Maguire in un ruolo che ricorda quello di Alfred Molina in Boogie Nights (1997) — ma ciò che viene dopo accentua ulteriormente il problema principale di Babylon: Chazelle si preoccupa più del viaggio che del singolo personaggio che lo subisce.

Con la consapevolezza che questo progetto da 80 milioni di dollari potrebbe essere l’ultimo del suo genere, Babylon riflette la prima grande crisi d’identità di Hollywood attraverso l’idea che noi stiamo vivendo la sua ultima. Il cinema è tutt’altro che morto, arriviamo a capire grazie allo sguardo finale di speranza regalatoci da Diego Calva, con la faccia ancora piena di lacrime al seguito di uno strano montaggio fatto di scene celebri dalla storia del cinema — che forse mi sarei goduta di più se fosse stato realizzato prendendo vita dall’immaginario di Chazelle stesso, anziché grazie a prestiti da quello altri. Il cinema è vivo, il cinema è vita, è qualcosa più grande di noi, è qualcosa di eterno ed eccezionale. Va bene Damien, lo abbiamo capito fin dall’inizio, mi trovi totalmente d’accordo, tuttavia mi sfugge il momento in cui qualcuno abbia mai detto il contrario.