a cura di marco morelli
Pensieri, parole, opere & omissioni dalla 82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia
priorità
Per chi ancora non l’avesse capito siamo un magazine di cinema e arti visive, come campeggia nella nostra pagina Instagram (a proposito, andate a recuperare i gustosi daily veneziani di Lorenzo, Costanza e Alberto!). La geopolitica non ricade necessariamente nel nostro campo di expertise, sebbene la materia sia spesso collegata al cinema internazionale e ci sia capitato di affrontare gli effetti della Storia su una popolazione e sul medium stesso. Pertanto, riteniamo doveroso iniziare il sunto veneziano con le significative dimostrazioni di affetto e solidarietà nei confronti del popolo palestinese. La Mostra era iniziata con una lettera firmata da circa mille addetti ai lavori che esortava la Biennale a non trascurare il genocidio palestinese, richiedendo in un secondo momento di ritirare l’invito a Gal Gadot e Gerard Butler. Ai due attori, presenti nello strombazzato In the hand of Dante di Julian Schnabel, era stata imputata una vicinanza all’IDF: nessuno dei due alla fine è sbarcato a Venezia, anche se si vocifera che la loro presenza non fosse comunque prevista.

A queste richieste non erano inizialmente seguite risposte dal Presidente Buttafuoco e dal Direttore Barbera; a domanda specifica su Gaza durante la press conference di apertura il Presidente di Giuria Alexander Payne aveva pavidamente glissato e a lui si è poi unito il silenzio di MUBI riguardo i finanziamenti di Sequoia Capital. Solo l’intervento del Leone d’oro Jim Jarmusch domenica 31 agosto ha mostrato, perlomeno, una sempre più rara schiettezza e onestà intellettuale. L’attivismo non si è limitato alla lettera: almeno cinquemila persone (anche volti noti dello spettacolo) hanno partecipato alla manifestazione di sabato 30 agosto al Lido, tantissimi artisti (tra cui un emozionato Nino D’Angelo) hanno menzionato Gaza durante la cerimonia di premiazione e, soprattutto, The voice of Hind Rajab è stato senz’altro il film più memorabile di questa Mostra.
Il film di Kaouther Ben Hania è risultato il più discusso e apprezzato dalla critica, ricevendo la standing ovation più lunga della Mostra (per quanto possa valere) e segnando il dibattito pubblico della scorsa settimana. Personalmente, sebbene nutra ancora qualche riserva etica sulla tecnica filmica, la visione in anteprima stampa è stata tra le più strazianti e indimenticabili che ricordi: mi auguro che presto tutti possano provarla sugli schermi nostrani, dato che I Wonder Pictures ha già annunciato che dal 25 settembre il film sarà distribuito in sala. Free Palestine.

il resto del palmarès
Alla luce di quanto scritto sopra ha fatto un po’ scalpore l’assegnazione del Leone d’oro a Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch. Il nativo di Akron era arrivato in Laguna senza grosse aspettative, specialmente perché la partecipazione sembrava un ripiego dopo il presunto rifiuto di Thierry Frémaux conseguente al flop di Dead Don’t Die del 2019 (comunque citato nel bellissimo Fallen Leaves dell’amico Aki Kaurismaki). Sebbene a noi il minimalismo malinconico di Father Mother Sister Brother sia piaciuto molto non possiamo certo definirlo un critics’ darling di questa Mostra confrontando i pareri dei media internazionali. Alla luce delle vociferate polemiche all’interno della giuria risulta plausibile che il film di Jarmusch sia stato scelto come vincitore assoluto in quanto titolo che accontenta tutti, un po’ come Dheepan a Cannes nel 2015 a discapito di Carol e Il figlio di Saul. Ad ogni modo, la scelta evidenzia due tendenze recenti in Laguna: premiare un autore classico ancora senza riconoscimenti (come fu per Almodóvar lo scorso anno) e una produzione americana (settimo dal 2017, ottavo se consideriamo hollywoodiano Cuarón).

Se sulle sezioni parallele (torneremo poi su Mata Hari) e sul palmarès attoriale (molto brava e bella Xin Zhilei, Servillo prevedibile) non abbiamo niente da aggiungere, altri premi ci hanno lasciato sbigottiti. Sorprende il Leone d’argento alla regia a Benny Safdie per The Smashing Machine, la cui formula non differisce abbastanza da altri sports drama anni ‘80, a discapito di autori come François Ozon e, soprattutto, Park Chan-wook. I due non hanno ancora ottenuto un riconoscimento simile e, in particolare, No other choice a bocca asciutta ha il retrogusto di occasione mancata, dal momento che il regista coreano era sempre stato un habitué di Cannes. Inspiegabile il Premio della giuria a Sotto le nuvole di Gianfranco Rosi, che non aveva certo brillato tra pubblico e critica e il cui posizionamento all’interno del Concorso era già sembrato sospetto; più scontata la sceneggiatura per À pied d’œuvre di Valérie Donzelli, che ha comunque il pregio di essere uno dei pochissimi film sui 90 minuti di durata di questo interminabile Concorso.

la mia personale “fittonata”
Sarebbe troppo scontato definire il mio highlight personale a Venezia l’intervista con la divina e disponibilissima Shu Qi, nettamente il primo argomento di conversazione con amici e parenti da quando sono tornato a casa; pertanto, mi limiterò a segnalare qual è stata la mia proeizione preferita di questa Venezia. L’aspetto che più adoro dei festival è trovare nel mare magnum di film quello che mi segna personalmente e che mi lascia pensare per giorni: a Berlino mi era successo per Drømmer e per il restauro dello splendido Shénnǚ. Memore di quest’ultima esperienza ho cercato di inserire nel mio programma diversi Classici restaurati, ma solo Aniki Bóbó di Oliveira (ultima esperienza in sala prima di partire) ha rispettato parzialmente le mie altissime aspettative. Ho aspettato la folgorazione fino a praticamente l’ultimo giorno in un Concorso fino a quel momento senza acuti: per fortuna, per soddisfarmi è intervenuta Ildikó Enyedi con il suo Silent Friend.

La regista ungherese, che aveva già sfoggiato interesse nell’esplorazione dei sogni nello splendido Corpo e anima, qui si concentra maggiormente sulla ricerca neuroscientifica (particolarmente apprezzata da un neuropsicologo in formazione) e botanica per suffragare possibili connessioni inter-specie tra umani e piante. Il film, attraverso un secolare ginkgo biloba (pianta estremamente affascinante, come direbbero gli amici di Ginkgomag) di un’università tedesca esamina tre periodi storici (1908, 1971, 2020) usando stili diversi (rispettivamente 35mm, 16mm e digitale) e mettendo sempre al centro le relazioni umane. Insieme al ginkgo assistiamo ai cambiamenti della storia (la misoginia delle istituzioni universitarie di inizio secolo, i movimenti di contestazione post-68, la recente pandemia di COVID) e della scienza con, alla base, sempre lo stesso bisogno di formare connessioni e comunicare con l’altro. Michael Haneke una volta disse che l’arte non deve fornire risposte quanto formulare delle domande: risulta impossibile non porsele dopo un’opera così evocativa che fa riflettere sulla necessità di stringere rapporti umani in un contemporaneo così frammentato. Silent Friend, placido e contemplativo, è senza dubbio il mio personale Leone d’oro di questa edizione e il film che mi porterò dietro con maggiore affetto.

quale futuro per la mostra
Ci si aspettava tanto da questa edizione: nomi altisonanti, programma ricco di spunti e, in generale, l’impressione che il Concorso potesse nella sua interezza battere un’edizione di Cannes che mancava un po’ di starpower. Pur non avendo ancora visto i titoli della Croisette di quest’anno la sensazione è che i proclami su Venezia non siano stati del tutto rispettati. Come notato da Roberto De Gaetano per Fata Morgana l’influenza dello streaming e delle piattaforme si fa sempre più ingombrante: per chi scrive i tre i titoli di Netflix sono stati tra i più scialbi, conservatori e carenti della competizione. Sorprendono sempre meno, pertanto, i gustosi fischi alla presentazione della N rossa durante le anteprime stampa. Anche le opere dei grandi autori europei (Lanthimos, Nemes, Assayas) sono sembrate minori rispetto alle loro filmografie e permane l’idea che una sezione ricca come Orizzonti non sia mai abbastanza pubblicizzata come accade, per esempio, a Un Certain Regard.

Questa tendenza conservatrice si rivela anche nella scelta dei registi in concorso. Oltre a uno sbilanciamento verso italiani e statunitensi è palese un’assenza di nomi nuovi, rispecchiatasi in una proposta cinefila poco rischiosa (tranne per i film di Enyedi e Maresco) e avveniristica. Di contro, Cannes quest’anno si è segnalata per aver pushato e consacrato autori che potrebbero essere centrali nei dibattiti cinefili dei prossimi decenni: Oliver Laxe, Bi Gan, Mascha Schilinski e Carla Simón, oltre alla già affermata Julia Ducournau.

La Mostra è stata tuttavia impreziosita dal Fuori Concorso, non tanto per le serie (di cui qualsiasi cinefilo potrebbe fare a meno) quanto per i documentari. Abbiamo già accennato a un’opera cinefila come Mata Hari e la scelta di proporre una serie di documentari sul cinema nella sezione Classici è risultata azzeccata; tuttavia, si percepisce ancor più amore per la Settima Arte nei docu fuori concorso. La metafora di Ben Hur del contadino Chuschagasta in Nuestra Tierra, la fascinazione per Catherine Deneuve in Marc by Sofia, l’esplorazione cinematografica come magnifica ossessione e ricerca del limite in Ghost Elephants e la riflessione contemplativa sulle immagini statiche di Back Home rappresentano alcune tra le più lampanti testimonianze che il cinema è ancora vivo nella produzione e nel pensiero contemporaneo. Sebbene risulti ancora inspiegabile l’esclusione di queste opere dal Concorso a discapito del film di Rosi, il regista di Sotto le nuvole nella cerimonia di premiazione ha parlato del documentario come forma di resistenza: mi auguro che il futuro di Venezia possa orientarsi più su questo viscerale amore per il Cinema che sulla caotica, cacofonica accozzaglia di star percepita fin troppe volte in questi giorni.



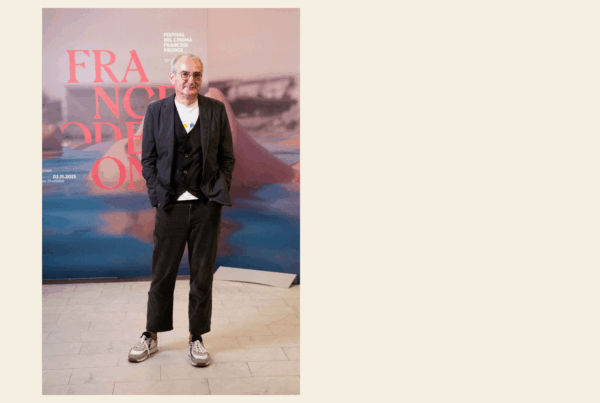

One Comment