recensione a cura di marco morelli
Olivier Assayas è uno dei volti centrali del cinema Europeo. Il figlio del regista Jacques Remy vanta una carriera quasi quarantennale e può essere reputato il figlio spirituale della Nouvelle Vague, considerando il suo periodo da critico nei Cahiers du Cinéma e i legami che ha stretto con alcuni dei volti più noti del periodo come Jean-Pierre Léaud. Già presente a Venezia con Apres Mai, Doubles vies e Wasp Network, Assayas torna in Concorso in Laguna con Le Mage du Kremlin. Il film, scritto a quattro mani dal regista ed Emmanuel Carrère, è tratto dall’omonimo romanzo del saggista e consigliere politico Giuliano da Empoli.

Il libro, pubblicato nel 2022, ha suscitato plausi (come l’assegnazione del Grand Prix du roman de l’Académie française) ma anche critiche, soprattutto negli Stati Uniti, per un ritratto ritenuto troppo simpatetico nei confronti di Putin. Ciò non ha impedito ad Assayas – vicino di casa di da Empoli, come rivelato in conferenza stampa – e Gaumont di sviluppare il progetto, affidando le parti principali a un cast internazionale di rilievo: Paul Dano, Jude Law, Jeffrey Wright e Alicia Vikander, che torna a collaborare con il regista dopo lo splendido Irma Vep. Nell’eclettica filmografia di Assayas emerge, tra gli altri, un certo interesse per la politica, specialmente negli anni della Guerra Fredda: è questo il caso dei già citati Apres Mai e Wasp Network ma anche della miniserie Carlos, considerato da alcuni il suo magnum opus[1]. Con Le Mage du Kremlin, il regista esplora le conseguenze della disgregazione dell’URSS sulla Russia, in particolare attraverso il punto di vista dello spin doctor Vadim Baranov, fautore dell’ascesa al di Putin da tenente del KGB a Zar contemporaneo.

Uno degli spunti più affascinanti del libro è l’analogia tra politica e teatro: Baranov, un tempo regista teatrale d’avanguardia, approda alla televisione per “inventare la realtà” anziché limitarsi a raccontare storie. Da lì, il passo successivo sarà orchestrare l’elezione di Putin a Primo Ministro e poi a Presidente. Assayas, da sempre interessato alle meta-rappresentazioni (Irma Vep, Sils Maria), sembra a suo agio con questa prospettiva: lo dimostrano le sequenze sugli spettacoli teatrali di Baranov e l’uso sapiente di filmati d’archivio, reali (Gorbačëv, gli attentati del ’99, le rivolte in Ucraina) e fittizi (con Putin protagonista). La centralità della messinscena nella vita politica – già evidenziata da eminenti politologi[2] – emerge in particolare nei capitoli finali, dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Sochi 2014 alla manipolazione, dietro le quinte, dei movimenti di protesta: colpisce il disprezzo che Baranov prova per gruppi simili ai sessantottini, che Assayas aveva invece ritratto con affetto in Après Mai.

Come in altri lavori, il debordiano convinto Assayas non si schiera apertamente sulla vicenda ma, piuttosto, offre una visione complessa sul panorama politico dopo il crollo dell’URSS e sul popolo russo. Fin dall’inizio emerge l’idea che il due blocchi della Guerra Fredda esistano ancora, e che i russi differiscano dagli occidentali per valori, tradizioni e mentalità. Ciò che noi europei riteniamo giusto non corrisponde sempre alla loro idea: questo emerge nei sondaggi di popolarità che vedono tuttora Stalin e Putin molto amati in Russia, oltre ai risultati delle ultime elezioni politiche in Russia in cui lo Zar ha aumentato i propri consensi. Il film, tuttavia, mostra anche la mancanza di democrazia e il pericolo dei russi attraverso il personaggio del narratore iniziale e il finale thriller e diverso dal romanzo di Da Empoli. Assayas segue fin troppo pedissequamente lo schema e le vicende del libro, salvo il finale e la caratterizzazione di Ksenia. Qui il personaggio assume il ruolo non solo di oggetto di amore ma di vera e propria bussola morale per il protagonista: il suo spirito indipendente contrasta il grigio autoritarismo del nuovo governo e, al contempo, rappresenta l’anima russa più intellettuale e artistica, come confermato in sala dagli stessi Assayas e Vikander. I momenti di intimità tra lei e Vadim, come quando si ricongiungono o il loro ultimo viaggio a Stoccolma, sono i più significativi della pellicola e risultano gestiti in maniera magistrale dal regista, che conferma la sua bravura anche nella scelta musicale (spunta anche Battiato, di cui si è dichiarato grande fan).
La parte politica, invece, appare più debole: per quanto Assayas si trovi a suo agio nelle atmosfere del romanzo non sembra offrire molto di più rispetto ad esso e alla sua precedente produzione, anche a causa di una durata e una verbosità eccessive che appesantiscono la narrazione e all’assenza dei fantasmi tipici del suo cinema. Ad ogni modo, Le Mage du Berlin risulta un’opera intrigante sul contemporaneo come altri grandi lavori del regista: dategli una chance appena uscirà in sala grazie a 01 Distribution.
[1] Wertz, R. J. (2011). The Jackal redux: a post-Marxist perspective on the life and crimes of Carlos the Jackal. In The Proceedings of the Laurel Highlands Communications Conference. Indiana University of Pennsylvania, Department of Communications Media.
[2] Fitzgerald S. (2015). Politics as theater. In Fitzgerald S (ed.) Spectators in the field of politics, (pp. 83–113). Palgrave Macmillan US.

![«le mage du kremlin» di olivier assayas [venezia82]](https://www.uncleyanco.it/wp-content/uploads/2025/08/MV5BNzQxYzdhYzEtMGI2Yi00ZTY0LWI0MzgtMWY3Y2QzNGI0MTJlXkEyXkFqcGc@._V1_-scaled.jpg)

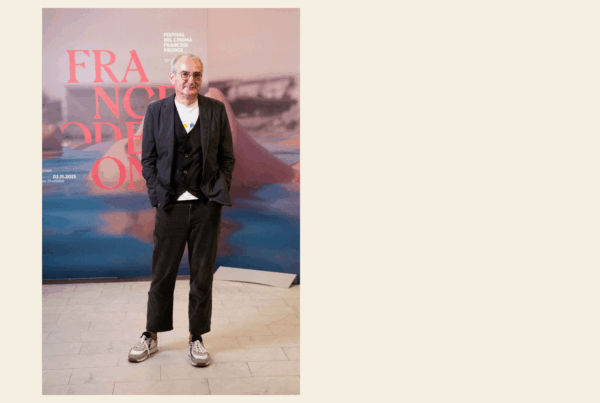
One Comment