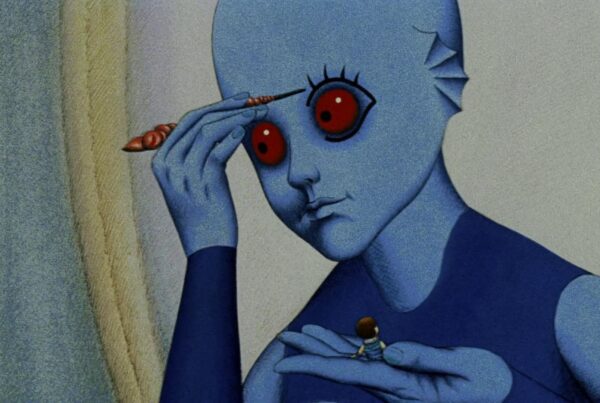recensione a cura di ilaria antonino
Un semplice incidente, primo film di Panahi da uomo libero dal 2010 e dopo la sua incarcerazione nel carcere di Evin tra il luglio 2022 e il febbraio 2023, è stato presentato al 78° Festival di Cannes – dove ha vinto la Palma d’oro – e ha visto la distribuzione in Italia dal 6 novembre con Lucky Red.

La vicenda nasce, in effetti, da un semplice incidente: un uomo sta rientrando a casa la sera con la sua famiglia, ma lungo la strada investe involontariamente un cane e danneggia la sua auto. L’uomo cerca dunque aiuto presso un’officina poco distante, dove Vahid, ex-detenuto politico, appare improvvisamente terrorizzato poiché crede di riconoscere in lui il suo aguzzino, Eghbal (“gamba di legno”). L* spettator* comprenderà in seguito che Vahid è stato allarmato dal cigolio della protesi della gamba destra dell’uomo, suono impresso nella memoria delle sue vittime. Il giorno dopo, Vahid rapisce il presunto torturatore per ucciderlo, ma, mentre lo sta seppellendo vivo, comincia a dubitare della sua identità. A bordo del suo van, Vahid riunirà allora altr* ex-prigionier* che hanno subito le sevizie di Eghbal (Shiva, Hamid, Golrokh e il futuro marito di quest’ultima, Alì) per aiutarlo nell’identificazione dell’agente del regime. L’operazione centrale dell’ultimo film di Panahi – il primo in cui il regista non figura nella lista dell* attor* – è la creazione di uno spazio, ad oggi inesistente (e non soltanto nella società iraniana), per pensare il dopo: cosa c’è dopo la violenza? Come arrestarne il ciclo? Come rendere possibile la convivenza di vittime e carnefici? Un semplice incidente non risponde a queste domande, né ha la pretesa di farlo.

Sete di vendetta, ira, compassione, pietà e morale sono affetti indissociabili e che si intrecciano in maniera contraddittoria durante tutto il film, la cui tensione culmina nella scena in cui Eghbal, che confessa essere il torturatore di Vahid, è legato a un albero, bendato e illuminato dalla luce rossa dei fari del van. Questo lungo piano sequenza, i cui mezzi stilistici sono ridotti al minimo necessario, adotta un punto di vista esplicitamente teatrale (la macchina da presa resta immobile e puntata sul viso di Eghbal) e incarna, rendendolo tangibile, il conflitto fino ad allora svoltosi in assenza del corpo dell’aguzzino, che resta rinchiuso in una cassa del van per quasi tutta la durata del film. È in questa scena, in cui vale la pena segnalare la prestazione brillante di Shiva[1] (Mariam Afshari), che il film pare più convincente e più vicino all’esperienza vissuta che a un problema teorico. I ruoli si ribaltano e Eghbal, Shiva e Vahid sono rappresentat* in tutta la loro complessità di esseri umani, di vittime, di carnefici, di padri di famiglia moss* da impulsi e sentimenti di furia ed empatia, feroci e incoerenti.

L’ora precedente pecca, infatti, di un didattismo eccessivo, come in un altro piano sequenza, anch’esso estremamente teatrale (il paragone con Aspettando Godot è tra l’altro esplicito), durante la quale la cinepresa si concentra su Hamid, il personaggio animato dai sentimenti più violenti e distruttivi del film. Hamid si sposta alternativamente dal van all’albero contro il quale Shiva è seduta, i due elementi che costituiscono i limiti del “palco”, e accusa tutt* l* altr* di codardia e debolezza. In questa scena, il dialogo tra l* present*, in assenza del carnefice, diventa un problema astratto, un confronto di ordine etico e morale privo di spessore materiale, più vicino a un trattato che a un’azione cinematografica. Allo stesso modo, i dialoghi nel van – simbolo della dimensione claustrofobica spesso presente nei film di Panahi, ma anche allegoria di un viaggio nel tempo, il passato della tortura, e di un’epopea morale – mancano spesso di dinamismo e gli accessi di rabbia dei personaggi non sono sufficienti a colmare le lacune della sceneggiatura. Panahi, in questo senso, malgrado il montaggio accurato e spesso efficace, è molto lontano dal suo maestro, Abbas Kiarostami.

Malgrado le sue debolezze, contenutistiche più che formali, Un semplice incidente apre dei margini di riflessione, che avrebbero forse potuto essere elaborati altrimenti, ma che restano di una bruciante attualità. Uscit* dalla sala, l* spettator* non ha risposte alle domande sollevate dal film, perché una risposta univoca, semplicemente, non esiste. L’ultima scena, in cui Vahid è ripreso di spalle, paralizzato dal suono della protesi di Eghbal (che pare avvicinarsi per poi allontanarsi), può essere allora l’annuncio di una nuova minaccia come della fine del calvario del protagonista. Come dice la figlia di Eghbal all’inizio del film, rispondendo a sua madre che le spiega che suo padre ha investito il cane per volontà di Dio, “lui (Eghbal) l’ha ucciso. Dio non c’entra niente”.
[1] È interessante notare che Shiva è diventata fotografa di matrimoni e che è la prima persona a cui si rivolge Vahid: prigioniera, Shiva era bendata e non poteva quindi vedere, mentre ora il suo lavoro è quello di perpetuare le immagini della realtà, di fissarne la verità, ciò che anche Vahid le chiede di fare quando la prega di identificare Eghbal.